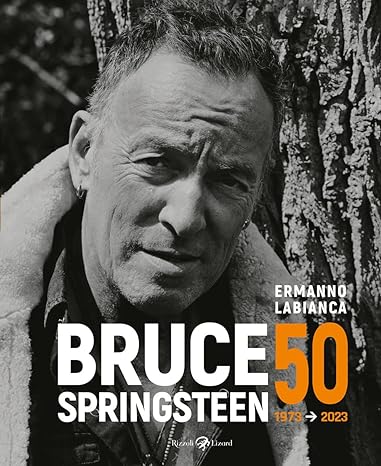HO VISTO IL FUTURO DEL ROCK AND ROLL ... (il famoso articolo di Jon Landau del 1974 interamente tradotto)
GROWING YOUNG WITH ROCK AND ROLL
Di Jon Landau
(pubblicato su Real Paper il 22 maggio 1974)
Sono le quattro del mattino e piove. Oggi compio 27 anni, mi sento vecchio; ascoltando i miei dischi mi viene in mente che le cose erano ben diverse un decennio fa. Era il 1964 ed io ero una matricola della Brandeis University, suonavo la chitarra e il banjo cinque ore al giorno mentre il resto del tempo lo passavo ascoltando dischi e, di notte, suonando con gli amici alla ricerca degli arrangiamenti delle canzoni dei Beach Boys e dei Beatles. Russell Gersten, che scriveva di musica soul su Real Paper, era il mio migliore amico e insieme ascoltavamo ogni giorno un sacco di 45 giri: “Walk on By” e “Anyone Who Had a Heart” di Dionne Worwick, “Up On the Roof” dei Drifters, “Selfish One” di Jackie Ross, “Too Many Fish in the Sea” delle Marvellettes e l’indimenticabile “Heat Wave” di Martha Reeves and the Vandellas. Quello stesso anno una donna speciale di nome Tamar mi suggerì di ascoltare “Midnight Hour” di Wilson Pickett e “Respect” di Otis Redding e fu così che scoprii la musica soul. Nel frattempo fui colpito dal sound dei Byrds di “Mr. Tamburine Man” e, più tardi, da “Younger than Yesterday”, che resta tuttora uno dei miei “good-night albums” preferiti. E la mattina, invece di bere il caffè, mi svegliavo con “Having a Rave Up” dei Yardbirds. Quando volevo cambiare genere c’era sempre il bluegrass: The Stanley Brothers, Bill Monroe, e Jimmy Martin.
Durante gli anni dell’università ascoltare musica era per me motivo di vita. Gli altri avevano le droghe, lo studio, i viaggi, le avventure. Io amavo la musica: ascoltarla, suonarla, discuterne. Mentre altri traevano ispirazione dall’acido, oppure dallo Zen, io ho seguito lo spirito del rock’n’roll. Alcune canzoni raggiungevano per me addirittura lo status di sacramento religioso. Un giorno di settembre, mentre attraversavo in macchina Waltham alla ricerca di un nuovo appartamento, fui colpito dal suono che usciva dalla mia autoradio. Mi fermai al lato della strada, parcheggiai, chiesi ai miei amici di fare silenzio e dopo 2 minuti e 56 secondi capiì che Dio mi aveva parlato attraverso “Reach Out, I’ll Be There”, un disco che porterò nel cuore finchè sarò vivo. Durante quegli anni, spesso solitari, la musica era la mia unica compagna di vita e cercare un nuovo disco era come cercare un nuovo amico, fare una nuova scoperta. “Mystic Eyes” mi fece scoprire la nuova miniera del rock and roll bianco; ci sono stati giorni in cui non andavo a dormire se non l’avessi ascoltato almeno una dozzina di volte.
Che il mio fosse un approccio nevrotico e maniacale alla musica, oppure una forma di religiosità, o entrambe le cose, non mi interessa. So solo che, oggi come allora, non posso che essere grato agli artisti che mi hanno fatto vivere queste esperienze, sperando che queste emozioni continuino ancora.
I dischi erano, ovviamente, solo una parte di tutto ciò. Nel ’65 e nel ’66 facevo parte di una band, The Jellyroll. Arrivai alla conclusione che il mio perfezionismo mi impediva di suonare insieme ad altri; avevo un carattere dittatoriale, avevo difficoltà a relazionarmi con altre persone e questo mi impidiva di condivide con loro la musica. Mi resi conto che non ero fatto per fare il musicista e così passai a fare il critico rock. Iniziando con alcuni pezzi su Broadside e poi scrivendo delle amatoriali ma convincenti recenzioni su i primi numeri di Crawdaddy riuscii a trovare un paliativo alla mia voglia di rock: se non ero capace di suonarlo forse era meglio scriverne.
Ma allora non mi ci vedevo come critico rock; la scrittura era solo una parte di quella mia ossessione. Mi dedicai alla musica dal vivo ancor più che ai dischi. Andavo al Club 47 tre volte a settimana ed ero sempre alla ricerca di concerti rock (non erano facili da trovare perché non sempre venivano suonati nei teatri del centro città). Sono andato a vedere gli Animals al Rindge Tech; i Rolling Stones, non solo al Boston Garden, dove assistei alla migliore mezz'ora di rock&roll della mia vita fino ad allora, ma anche al Lynn Football Stadium, dove scoppiarono dei tafferugli; ho visto Mitch Ryder e Detroit Wheels riuscire a suonare malgrado le condizioni disastrose del Watpole Skating Rink; e i Beatles al Suffolk Down, una buona acustica e in ottima posizione, come a conferma del fatto che noi – ed io – facevamo parte di quel speciale gruppo di persone che avevano compreso il potere e la gloria del rock’n’roll.
Vivevo quei giorni con un senso di attesa. Per qualche estate lavorai al Briggs & Briggs, ma il mio pensiero era sempre rivolto ai nuovi dischi in arrivo. La delusione per un giorno di ritardo dell’uscita dell’ultimo degli Stones si bilanciava con l’euforia per l’uscita, con una settimana di anticipo, di Another Side di Dylan. E poi l’emozione di sintonizzarsi su WBZ e ascoltare quel sound strano, bello e allo stesso tempo orribile, che richiedeva un nuovo ascolto; si trattava di “You’ve Lost That Loving Feeling”, una canzone che sta giusto un gradino sotto a “Reach Out I’ll Be There” come mio strumento di catarsi musicale. Purtroppo sono fatto così, odio quello che gli altri amano di più. Quella merda di San Francisco aveva corrotto la purezza del rock che più amavo così ho condotto una crociata contro di essa. I Moby Grape mi emozionavano, ma quelle canzoni che parlavano di conigli bianchi (ndt: White Rabbit è una canzone del 1967 dei Jefferson Airplaine) e amore hippie mi facevano ridere quando non mi facevano schifo. Ci sta più rock’n’roll nell’istericamente manipolato Got Live if You dei Rolling Stones che in tutti i dischi di San Francisco messi insieme.
Per ogni momento di questi che riesco a ricordare ce ne sono una dozzina che ho dimenticato, ma in una notte come questa sono tutti qui con me, fanno parte del mio io, un sentimento perso nella mente ma non nell’anima. Poi ci sono quelle esperienze personali così trascendentali che ricordo come fossero accadute ieri: Sam and Dave al Madison Square Garden nel 1967: ogni gesto, ogni movimento, l’ordine delle canzoni suonate. Darei qualsiasi cosa per sentirli cantare “When Something’s Wrong whit My Baby” come fecero quella notte. Le mie ossessione per Otis Redding, Jerry Butler e BB King venne un po’ più tardi; impiegai sei mesi della mia vita per metabolizzare ogni singola sfumatura di ogni loro album. Infine i Byrds: mi rivolgo a loro e li invito a cercare, e da loro me lo aspetto, qualcosa di veramente valido, qualcosa che si rivolga a me.
Non appena lasciai il college nel 1969 e iniziai a lavorare come produttore discografico la mia fino ad allora insaziabile fame musicale iniziò ad esaurirsi. Tuttora ascolto molta musica e un sacco di artisti, ma lo faccio con meno trasporto, meno passione. Sono diventato più esigente, più intransigente. Mi viene difficile ascoltare nuovi artisti. Ho accumulato sufficiente esperienza musicale alla quale attingere in caso di necessità, ma ultimamente ho scoperto di aver meno bisogno della musica e più bisogno di persone, quest’ultime quasi del tutto escluse, fino a poco tempo fa, dalla mia vita.
Oggi ascolto la musica con un senso di distacco. Sono un professionista e mi guadagno da vivere scrivendo di musica. Ci sono mesi in cui odio questo lavoro, la routine con cui lo faccio mi fa sentire come un qualsiasi venditore di scarpe. La passione con cui ascoltavo una volta la musica la riverso adesso sui film. Ma nei momenti difficili non ho smesso di cercare conforto nella musica, nei suoni che riescono a generare impulsi, che alimentano le emozioni, che puliscono e purificano – tutte cose che abbiamo il diritto di aspettarci dalle grandi opere d’arte, ma che purtroppo solo raramente avviene.
Oggi, se ascolto un disco che mi piace non sento più la necessità di cercare tutti gli altri dischi dell’artista. Lo prendo così come venie: l’ascolto, lo amo e poi lo lascio. Anche se qualcosa mi rimane: mi vengono in mente After the Goldrush di Neil Young, Innervisions di Stevie Wonder, Tutelo Honey di Van Morrison, i dischi di James Taylor, Exposed di Valerie Simpson, Sail Away di Randy Newman, Exile on Main Street, i dischi di Ry Cooder e, in particolar modo, gli ultimi tre dischi di Joni Mitchell, ma il resto scivola via, lasciando in me solo impressioni sbiadite, cosa che non succedeva per album simili una decina di anni fa.
Ma questa sera c’è qualcuno di cui posso tornare a scrivere alla maniera in cui scrivevo una volta, senza riserve di alcun tipo. Giovedì scorso, al Harvard Square Theatre, ho visto ricomparire davanti ai miei occhi il mio rock’n’roll. E ho visto un’altra cosa: ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen. E, in una notte in cui avevo bisogno di sentirmi giovane, mi ha fatto sentire come se stessi ascoltando la musica per la prima volta.
Quando il suo concerto di due ore è finito ho pensato: ma davvero esiste uno così in gamba, che riesce a dirmi ancora delle cose, può ancora il rock’n’roll rivolgersi a noi con questo tipo di potere e di gloria? Poi ho sentito le fitte sulle cosce martellate dalla mie mani per tutto il tempo del concerto e ho capito che la risposta era si.
Springsteen fa tutto. E’ un rock’n’roll punk, un poeta latino di strada, un ballerino, un attore, un joker, un leader di una bar band, un caldo fottuto chitarrista ritmico, uno straordinario cantante, oltre a essere un vero grande compositore di rock’n’roll. Dirige la band come se l’avesse fatto da sempre. Mi sono arrovellato il cervello ma non sono riuscito a trovare un artista bianco che sappia fare tutte queste cose in maniera così splendida. Non esiste nessuno che avrei voluto vedere oggi sul palco al suo posto. Ha aperto le danze con una favolosa “The E Street Shuffle” (così rallentata che sembrava una nuova canzone ma bella come la vecchia versione). Ha poi cantato “For You”, struggente storia che narra di un suicidio, accompagnandosi solamente al pianoforte e la sua voce toccante è arrivata fino all’ultima fila del Harvard Square Theatre.
Ha fatto tre nuove canzoni, tutte sul tema del rock di strada, una anche con una intro di chitarra Telstar e un’altra con un riff alla Eddie Cochran. Ci ha poi bombardato con una sua versione di “For Winds Blow”, che eseguì meglio nella sensazionale settimana al Charley, ma la versione di “Rosalita” è stata la migliore che abbia mai sentito e “Kitty’s Back”, uno dei più grandi “shuffle” contemporanei, mi ha fatto sobbalzare sulla sedia e trascinato con personalità la folla.
Vedere Bruce Springsteen suonare è uno spettacolo. Smilzo, vestito come uno degli Sha Na Na, schierato davanti alla band, si presenta come un incrocio tra Chuck Berry, il primo Bob Dylan e Marlon Brando. Ogni gesto, ogni parola aggiunge qualcosa al suo obbiettivo finale: liberarci lo spirito mettendo a nudo al sua anima attraverso la musica. Molti cercano di farlo, pochi ci riescono, nessuno, oggi, lo fa come lui.
Sono le cinque – sto scrivendo queste righe velocemente, e quindi spero di non fare errori – e sto ascoltando “Kitty’s Back”. So di essere vecchio, ma questa canzone e il ricordo del concerto mi fanno sentire un ragazzino. Riesco ancora a sentire quello spirito e riesco ancora ad emozionarmi. Questa settimana ho comprato una nuova casa e nella camera da letto al piano di sopra c'è una bella addormentata che riesce a capire bene cosa significhino per me i miei dischi e la mia macchina da scrivere. A proposito di rock and roll: I Lovin’ Spoonful cantavano “Voglio raccontarti la magia che libera la tua anima/ma è come parlare ad un estraneo di rock’n’roll”. Giovedì scorso ho capito che quella magia esiste ancora e che, fino a quando scriverò di musica rock, la mia missione sarà quella di raccontarlo agli altri – e scrivendo ciò mi rendo conto che l’estraneo per cui scrivo sono io.